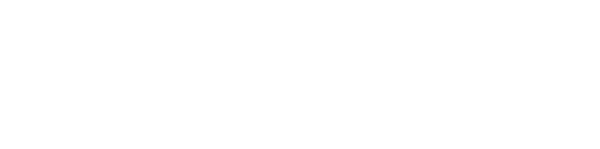Importante contributo dell’IRCCS ISN di Bologna allo studio dell’ISS sugli effetti del Long-COVID
Importante contributo da parte dell’IRCCS Istituto delle Scienze di Bologna allo studio “Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell’infezione COVID-19 (Long-COVID): bilanci e prospettive” lanciato dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute e che ha visto come capofila l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il progetto, messo in pista nel dicembre 2021 e coordinato dal Prof. Graziano Onder (IRCCS Gemelli di Roma) ha visto coinvolto tra gli enti anche RIN – rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, di cui l’IRCCS ISN di Bologna fa parte.
L’attività dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna all’interno del progetto è stata finalizzata in due diversi momenti. Martedì 21 maggio con la partecipazione attiva al convegno dal titolo “Long-COVID e malattie neurologiche: analisi degli effetti a lungo termine e strategie di intervento”, organizzato da RIN – rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, con il patrocinio di SIN (Società Italiana di Neurologia), che si è svolto a Roma presso il Centro Studi Americani, e il giorno seguente all’interno dell’evento conclusivo del progetto, il convegno “Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell'infezione COVID-19 (Long-COVID)” che si è svolto sempre a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità. In questo appuntamento il Dottor Lorenzo Muccioli dell’IRCCS ISN di Bologna ha portato i risultati delle più recenti acquisizioni, acquisite con il contributo al progetto dell’ISS da parte del Professor Rocco Liguori (UOC Clinica Neurologica), su Long-COVID e malattie neurologiche.
A distanza di oltre quattro anni dall’inizio della pandemia, appare evidente che per un rilevante numero di persone colpite da COVID-19 segni e sintomi causati dall’infezione possono persistere o svilupparsi anche dopo la risoluzione della fase acuta, precludendo il pieno ritorno al precedente stato di salute. Questa condizione è stata riconosciuta come una entità clinica specifica, denominata appunto Long-COVID. Sia durante il convegno RIN, che durante l’evento all’ISS, sono stati trattati gli effetti del contagio a livello neurologico, ma anche l'importanza di considerare l'interazione tra uomo, ambiente e mondo animale per comprendere, prevenire e gestire le pandemie.
“In questi due giorni abbiamo voluto portare l’attenzione sulle manifestazioni neurologiche successive all'infezione da SARS-CoV-2. – ha detto il Professor Raffaele Lodi, Direttore Scientifico dell’IRCCS ISN di Bologna, nonché Presidente della RIN - Ci siamo concentrati su due aspetti: gli effetti neurologici provocati dall'infezione, sia in fase acuta che nella fase successiva alla guarigione con particolare riferimento alle manifestazioni neurologiche legate soprattutto a disfunzioni cognitive e disturbi psichiatrici. L'altro aspetto importante che abbiamo approfondito è l'effetto dell'infezione da Covid-19 su malattie neurologiche preesistenti e croniche, come quelle autoimmuni e neurodegenerative. Infine, lanciando uno sguardo al futuro con il possibile effetto del Covid-19 sullo sviluppo di malattie neurodegenerative, potenzialmente anticipando il loro esordio in soggetti predisposti”.
Il Professor Luciano Onder, a capo del percorso finalizzato mercoledì 22 maggio, ha affermato: “Il progetto ha riunito numerosi attori che lavorano sul tema del Long-Covid, oltre all'Istituto Superiore di Sanità, le reti degli IRCCS, le università e tanti altri professionisti del settore. Grazie al loro lavoro abbiamo raggiunto tre macro obiettivi: valutare l'impatto del Long-Covid sul consumo di risorse a lungo termine, evidenziando il raddoppio del numero di ospedalizzazioni, delle prestazioni diagnostiche e delle visite; definire buone pratiche su come gestire e organizzare un centro che si occupa di Long-Covid; e sviluppare un sistema di sorveglianza che ha seguito nel tempo oltre 1.900 pazienti afferenti ai centri non-Covid”.
Il Professore della Cattolica ha sottolineato anche che il progetto “rappresenta una fonte importante di informazioni per ulteriori ricerche e per comprendere meglio il fenomeno Long-Covid. La grande quantità di dati ha permesso di informare la popolazione tramite il sito dell'Istituto Superiore di Sanità e di formare gli operatori sanitari. Abbiamo svolto una formazione a distanza (FAD) che ha coinvolto oltre 14.000 operatori sanitari su tutto il territorio nazionale. Quindi, un progetto che ha avuto un impatto significativo sulla sanità pubblica, la ricerca e la formazione, aggiungendo molto sul tema del non-Covid”.
Le stime della proporzione di persone che sviluppano il Long-COVID dopo l'infezione acuta sono molto variabili, oscillando da meno del 10%, al 20%–25% riportato dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti (CDC), a oltre il 50% riportato in una grande meta analisi. Più di recente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che circa il 10%–20% dei pazienti COVID-19 sperimentano sintomi persistenti dopo un'infezione acuta da SARS-CoV-2. Sebbene sia stato riportato che sia la vaccinazione contro SARS-CoV-2 sia la variante Omicron sono associate a una ridotta incidenza della condizione, dato il numero di centinaia di milioni di casi di COVID-19 in tutto il mondo, le proiezioni evidenziano che un alto numero di pazienti soffrirà di manifestazioni di Long-COVID con un impatto significativo sui servizi sanitari[1].
Il Long-COVID può colpire diversi sistemi, tra cui quello cardiovascolare, polmonare, della coagulazione ed ematologico, renale, gastrointestinale, muscoloscheletrico, così come, ovviamente, quello neurologico e psichiatrico, con significativi impatti su morbilità e mortalità. Tuttavia, la patologia rimane in gran parte sconosciuta, le conoscenze sugli strumenti migliori per la sua valutazione e diagnosi sono ancora incomplete e i trattamenti sono principalmente sintomatici. Inoltre, le risposte organizzative al problema in Italia variano notevolmente a livello regionale e manca una rete nazionale di sorveglianza e informazione dedicata.
[1] Bull-Otterson L, Baca S, Saydah BTK, Adjei S, Gray S, et al. Post-COVID conditions among adult COVID-19 survivors aged 18-64 and ≥ 65 years – United States, march 2020-November 2021. MMWR Morb Mortality Wkly Rep. (2022) 71:713–7. doi: 10.15585/mmwr.mm7121e1;
Groff D, Sun A, Ssentongo AE, Ba DM, Parsons N, Poudel GR, et al. Short-term and long-term rates of postacute sequelae of SARS-CoV-2 infection a systematic review. JAMA Netw Open. (2021) 4:e2128568. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.28568;
World Health Organization. (2022). Post COVID-19 condition. Available at: https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition (Accessed November 15, 2022);
Al-Aly Z, Bowe B, Xie Y. Long COVID after breakthrough SARS CoV-2 infection. Nature Med. (2022) 28:1461–7. doi: 10.1038/s41591-022-01840-0;
Hastie CE, Lowe DJ, McAuley A, Winter AJ, Mills NL, Black C, et al. Outcomes among confirmed cases and a matched comparison group in the Long-COVID in Scotland study. Nat Commun. (2022) 13:5663. doi: 10.1038/s41467-022-33415-5;
Antonelli M, Pujol JC, Spector TD, Ourselin S, Steves CJ. Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. Lancet. (2022) 399:2263–4. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00941-2